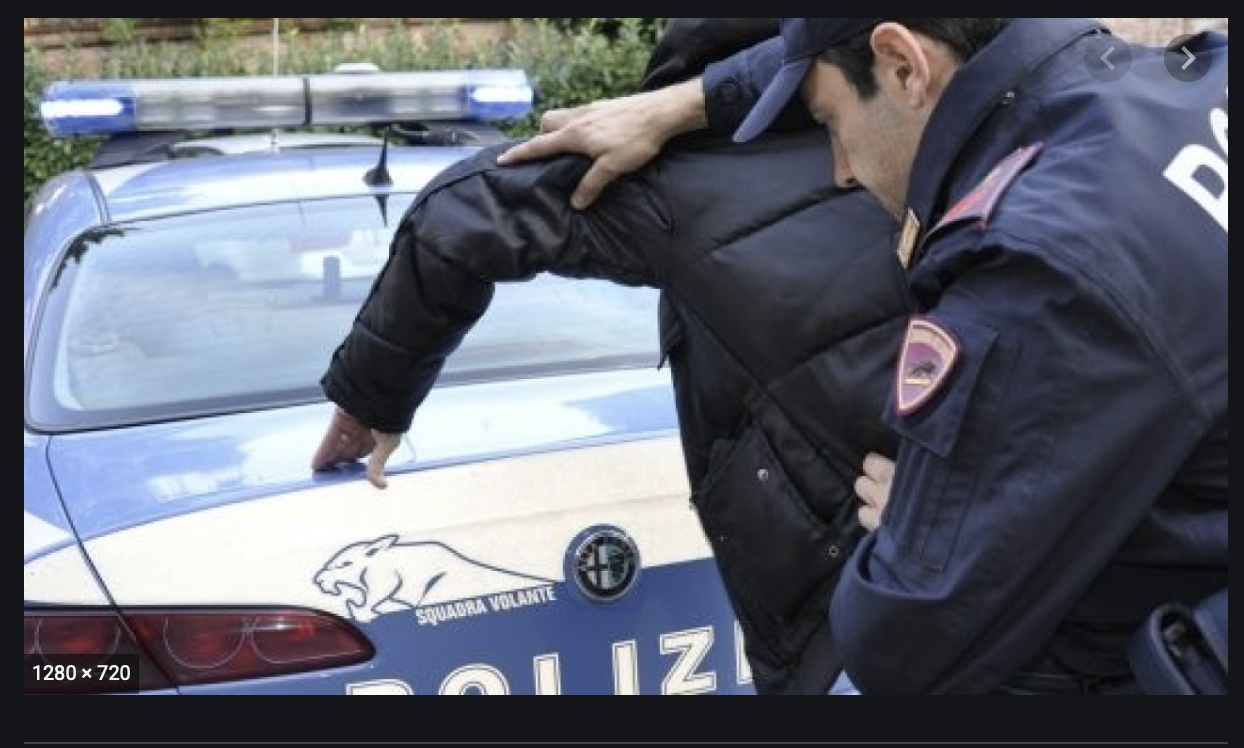DELITTI CONTRO LA P.A.: RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
In via preliminare, si osserva che la fattispecie penale incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale è da considerare come un delitto di medio allarme sociale. Tuttavia, l’allarme sociale generato e prodotto dal predetto reato può, talvolta, crescere ulteriormente ed essere, quindi, il presupposto, l’antefatto per la realizzazione di più gravi reati quali ad esempio l’omicidio.
Il legislatore penale colloca la resistenza a un pubblico ufficiale nel libro II del codice penale, nel titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), nel Capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione). Pertanto, l’articolo 337 del vigente codice penale stabilisce che: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Si tratta di un reato comune, giacché può essere commesso da una qualsiasi persona fisica, di danno , in quanto richiede l’offesa in senso naturalistico del bene protetto, di mera condotta ed a forma libera, poiché può essere realizzato con qualsiasi condotta idonea al raggiungimento dello scopo. Inoltre, il tentativo è pienamente configurabile.
Il soggetto passivo del reato in commento può essere un pubblico ufficiale[1], un incaricato di un pubblico servizio ovvero chiunque, da questi richiesto, presti loro assistenza. Tuttavia, si deve correttamente rilevare che non rientrano fra i soggetti passivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità (ad esempio gli avvocati).
In tema di resistenza a pubblico ufficiale il bene giuridico protetto è quello della sicurezza e della libertà di azione, di movimento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio contro specifici fatti di opposizione violenta. In particolare, per la configurabilità dell’elemento materiale della violenza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la condotta violenta ponga in pericolo l’integrità fisica del soggetto passivo, poiché il delitto di cui all’articolo 337 c.p. è un reato contro la Pubblica Amministrazione e non contro la persona. Infatti, è sufficiente l’esistenza di una condotta idonea ad impedire l’esecuzione dell’atto di ufficio. Si ritiene che la materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale sia integrata pure dalla violenza cosiddetta impropria, la quale, pur non aggredendo direttamente il predetto soggetto, si ripercuote sfavorevolmente nell’esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola.
Inoltre, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualunque attività commissiva od omissiva che si trasponga in un atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile “ex adverso”, che impedisca, ostacoli, intralci ed valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell’atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell’ incaricato di un pubblico servizio. Dalla lettura della norma viene in evidenza che l’atto dell’ufficio o del servizio deve aver avuto almeno un principio di esecuzione. Infatti, l’utilizzazione normativa dell’avverbio “mentre” determina la necessaria contestualità tra la resistenza e l’attività del pubblico funzionario.
Tuttavia, non ogni reazione minacciosa è valida ad integrare il reato in commento. Infatti, non integra il reato di cui all’art. 337 codice penale la reazione minacciosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già svolto l’atto del proprio ufficio e senza, dunque, la finalità di opporvisi. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 marzo 2011, n. 8340) Inoltre, estranea ai confini della condotta violenta o minacciosa è la cosiddetta resistenza passiva consistente in comportamenti meramente difensivi quali buttarsi a terra o rifiutarsi di obbedire, anche nel caso in cui il pubblico ufficiale sia costretto ad adoperare violenza per vincerla (si veda in tal senso la Cassazione penale, Sezione VI sentenza 06 novembre 2012 n. 10136).
Il coefficiente psicologico[2] ricercato è il dolo specifico[3], in quanto oltre alla coscienza e volontà della violenza o minaccia è richiesta l’ulteriore finalità di impedire che l’agente pubblico esegua l’atto del suo ufficio. Tuttavia, si deve osservare che nel reato in commento sono estranei, per l’individuazione dell’elemento soggettivo, la causa ed il fine del soggetto del reato.
Secondo un importante insegnamento del Supremo Collegio, l’elemento intenzionale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale si concreta nella coscienza e volontà dell’agente di usare violenza o minaccia per opporsi al soggetto tutelato mentre sta compiendo o si sta adoperando per compiere il proprio atto d’ufficio o di servizio, senza che abbia rilevanza il fatto che la violenza o minaccia cada su cose anziché sulle persone, quando essa sia idonea ad impedire o, comunque, turbare od ostacolare l’attività funzionale del pubblico ufficiale. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza del 27 maggio 1986 nr. 4325) In sostanza, il predetto principio di diritto, correttamente enucleato dalla Cassazione, chiarisce che per la realizzazione ed il perfezionamento del reato in commento è indifferente che la condotta antigiuridica della violenza o della minaccia avvenga ed cada su cose piuttosto che sulle persone.
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l’elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di precludere al pubblico ufficiale con una condotta minacciosa e violenta l’atto d’ufficio ritenuto pregiudizievole per i propri interessi. Ne consegue che risponde del reato su indicato colui il quale abbia nei confronti di un vigile urbano in servizio e che gli richieda dei documenti per l’identificazione una condotta tanto violenta da produrgli delle lesioni personali. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 14 marzo 1986, n. 2089)
La resistenza a pubblico ufficiale è, purtroppo, un reato molto diffuso e di frequente verificazione nell’attuale società civile. Si pensi, solo per fare un esempio, alla condotta del conducente di un automezzo che, senza fermarsi all’alt degli agenti di un organo di polizia stradale, decida di speronare violentemente ed a forte velocità l’autovettura di servizio degli agenti di polizia proprio al fine di non consentire loro l’espletamento di un atto d’ufficio.
Inoltre, desta particolare interesse per la sua portata chiarificatrice una sentenza della Corte di Cassazione che affronta la problematica del reato continuato , del concorso formale di reati ed anche quella del rapporto fra il tentato omicidio e la resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice delle leggi, in riferimento a quanto esposto in precedenza, ha stabilito che : “Il reato di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessario per impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio, mentre l’omicidio, travalicando detto limite, attenta direttamente alla vita od all’incolumità del soggetto passivo; i due reati possono concorrere, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e le differenze qualitative e quantitative della violenza esercitata contro il pubblico ufficiale”. Nella predetta fattispecie la Suprema Corte ha opportunamente ed correttamente ravvisato il concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio nella condotta dell’indagato che, in fuga a bordo di un’autovettura appena rapinata, aveva a più riprese tentato di investire la motocicletta a bordo della quale due agenti di P.G. lo inseguivano. (Cassazione penale, sezione II, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38620).
Si osserva, nuovamente, che nella resistenza a pubblico ufficiale può essere applicato anche l’istituto giuridico del reato continuato (art. 81 c.p.). Infatti, la plurima violazione della legge penale può avere ad oggetto la stessa norma prevista dall’articolo 337 c.p. Pertanto, solo per fare un esempio, qualora la pubblica funzione sia esercitata da una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio attraverso singole azioni che si integrano a vicenda, la pluralità delle contrapposte reazioni minacciose o violente con cui l’autore della resistenza intenda bloccare le predette complesse funzioni rientra nel paradigma del reato continuato.
Inoltre, merita di essere brevemente trattato anche il profilo del concorso di persone nel reato. Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, si osserva che la mancanza del previo concerto non condiziona la configurabilità del concorso di persone nel reato, essendo sufficiente l’intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell’esecuzione del fatto criminoso.
In riferimento ai rapporti che intercorrono con altre fattispecie penali incriminatrici molto interessante ed articolato si presente il seguente principio di diritto: “Quando la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l’impunità, nei confronti del pubblico ufficiale, al fine di opporsi mentre compie un atto dell’ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e resistenza e quello di lesioni, e per quest’ultimo sussiste l’aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato – mezzo e reato – fine siano integrati dalla stessa condotta materiale”. (Cassazione penale, sezione II, sentenza 18 luglio 2005 nr. 26435)
Sempre in riferimento ai rapporti con altri reati la giurisprudenza di legittimità ha enucleato il seguente principio di diritto : “È configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non quello previsto dall’art. 336 c.p., nella condotta di colui che minaccia un agente di polizia per opporsi all’esecuzione di un sequestro, quando dopo l’apprensione materiale della res sia ancora necessario provvedere alla compilazione degli atti conseguenti al sequestro”. (Cassazione penale, sezione VI, 10 ottobre 2008, n. 38566)
Orbene, sulla base della precedente riflessione e considerazione, si osserva che è proprio il criterio cronologico che differenzia la resistenza a p.u. dalla violenza o minaccia a p.u. Infatti quando l’atto attende ancora di essere compiuto (prima dell’inizio della sua esecuzione) è possibile il delitto di violenza o minaccia mentre, invece, quando l’atto è iniziato (in via di compimento) e sino al termine della sua esecuzione è possibile il delitto di resistenza.
Restano ancora da analizzare alcune brevi note procedurali per il reato in commento. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio che è di competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 33 – ter c.p.p.) ; la misura pre-cautelare dell’arresto[4] è facoltativa mentre, invece, il fermo di persona indiziata di delitto non è consentito. Inoltre, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere è consentita al pari di tutte le altre misure cautelari personali. L’azione penale si esercita con il decreto di citazione diretta a giudizio e l’udienza preliminare non è prevista. Il reato si prescrive nel termine di sei anni e la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto risulta essere possibile.
Al delitto di resistenza a pubblico ufficiale si applica, altresì, l’esimente di cui all’articolo 393-bis c.p. (Causa di non punibilità). Infatti, secondo l’insegnamento della Cassazione Penale, sezione VI, sentenza 14 aprile 2011, n. 18841, è configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità. In sintesi, la causa di non punibilità, di cui all’articolo 393 bis c.p., deve essere applicata ogni qual volta il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbiano dato causa al fatto previsto dall’articolo 337 c.p., eccedendo con degli atti arbitrari i limiti delle loro proprie attribuzioni di legge.
In ultima analisi, si osserva come sussiste l’elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorchè l’autore del fatto sia consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta la qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un’attività del proprio ufficio. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 16 aprile 2004, n. 17701)
(A cura del Dott. Alessandro Amaolo, Specializzato nelle Professioni Legali con indirizzo Giudiziario – Foresnse ed abilitato all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Ancona)
[1] Le guardie giurate, ancorché in servizio presso pubbliche amministrazioni, svolgono esclusivamente compiti di tutela delle entità patrimoniali affidate alla loro sorveglianza e non possono assumere, pertanto, la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio quando intervengano, al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali, per sedare una lite insorta fra un privato ed un pubblico dipendente. Infatti, nella predetta fattispecie la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 337 c.p. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 05 dicembre 2008, n. 45444)
[2] Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, l’elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di precludere, con la propria condotta minacciosa o violenta, la possibilità di compiere l’atto di ufficio ritenuto pregiudizievole ai propri interessi. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 febbraio 1988, n. 1506)
[3] In tema di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall’agente. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 25 agosto 1995, n. 9119)
[4] In tema di arresto facoltativo in flagranza, il controllo, che il giudice che procede alla convalida dell’arresto è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 391 c.p.p., deve limitarsi all’accertamento delle condizioni di legittimità dell’arresto stesso (quali la flagranza del reato e i presupposti indicati dagli artt. 385 e 386 cod. proc. pen.), non potendosi estendere alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità, che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservata al giudice della cognizione. (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 febbraio 2009, n. 6878)